Le indicazioni che diamo o riceviamo per le nostre comunità e che dovrebbero permettere loro di vivere meglio (secondo il Vangelo e qualche volta secondo il buon senso), non di rado sono temerarie. Non per questo, a quelle indicazioni si dovrebbe rinunciare. Non considerare, però, quella «temerarietà» fa correre il rischio di renderle «lettera morta».
Un esempio drammatico e che riguarda tutta la comunità umana: la pace. Esortare alla pace è doveroso. Tuttavia, pensare che dall’esortazione verrà la pace, appare… temerario, appunto, se quella esortazione non fa i conti con un dato non trascurabile: nei gruppi umani la normalità è il conflitto; la pace, una anomalia. Pensare che le cose possano andare in modo diverso, non significa trascurare la letteratura esistente in psicologia dei gruppi, ma quell’esempio tragico di scissione sociale che è il conflitto tra fratelli, così come raccontato da Gen 4. Il testo segnala che alle fondamenta della fraternità sta il conflitto. E siccome il termine fraternità è ricorrente nelle nostre parole, ignorare che «in principio» c’è quella roba lì, significherebbe chiamare in causa un’esperienza che probabilmente non esiste.
Unità e individualismo
Con l’unità del presbiterio le cose non vanno troppo diversamente. E in modo particolare, proprio di questi tempi. Pur consapevole della semplificazione che faccio, direi che le portanti culturali di molti Paesi dell’Asia riconoscono un primato al sociale che renderebbe l’unità – dunque pure quella di un presbiterio – una faccenda tutto sommato praticabile. Eppure, non di rado, sono gli stessi amici asiatici – anche coloro che vivono in Paesi efficienti e superorganizzati – a riconoscere negli individualisti europei e americani il raggiungimento di uno stile di vita più felice. Quello stile, gli asiatici, probabilmente non lo adotterebbero; eppure un po’ lo invidiano.
In effetti, nonostante le svolte interpersonali della Filosofia e delle scienze umane, probabilmente oggi siamo individualisti come non mai. E se la cosa un po’ si vede quando un nostro giovane diventa prete, molto di più balza all’occhio quando quello stesso giovane decide di lasciare il ministero. Non discuto le ragioni di nessuno, ma l’assenza delle altre persone, in quel frangente comunque complicato, non di rado è perfino clamorosa.
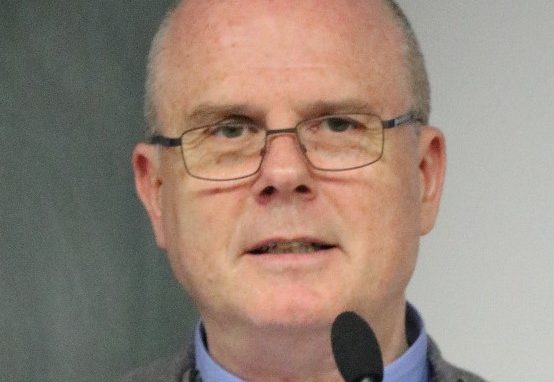
Una proposta pastorale che sottolinei l’importanza del passaggio dal presbitero al presbiterio, se non si fa carico di quel movimento culturale che spontaneamente va in direzione contraria, rischia di cadere nel vuoto.
Occorrono mediazioni.
Un ingegnere cristiano chiamato a progettare un ponte non prega affinché il ponte stia su. A permettere al ponte di stare su provvederanno le sue conoscenze di statica, dei materiali, del terreno, il lavoro duro… In ultima analisi: la coscienza sua e di molti, rafforzata forse anche dalla preghiera. Progettare un ponte, infatti, significa pensare al bene di tutti coloro che lo attraverseranno e in nome di quel bene varrà la pena rinunciare a qualche ora di sonno per perfezionare i calcoli. La preghiera, però, mai sostituirà la qualità di un progetto e della sua esecuzione.
Un vescovo dovrebbe fare qualcosa di simile. La preghiera potrebbe educarlo alla consapevolezza di quelle mediazioni senza le quali le indicazioni, anche se buone, non possono germogliare. La preghiera è trasformativa. Non è pensiero magico. Vale per gli ingegneri; vale pure per i preti, i diaconi e i vescovi.






