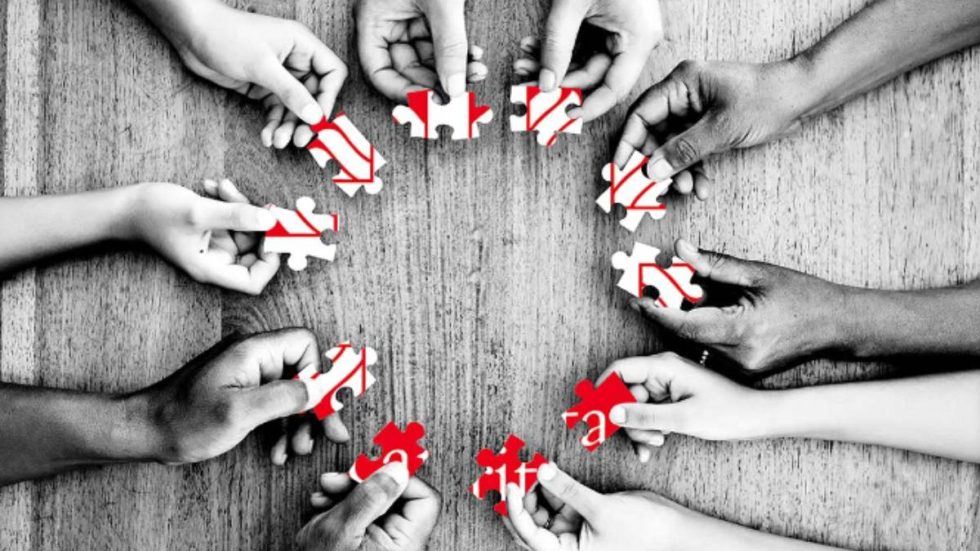«Sono una nonna: vorrei consultare il mio fascicolo sanitario e prenotare una visita, ma sul telefonino appaiono scritte strane e i miei occhi e le mie dita si imbrogliano, quando c’è da pigiare i tasti giusti…». «Sono una persona con disabilità: vorrei avere una socialità come tutti, oltre le opportunità che la domotica mi offre quando sono a casa, ma non è facile coltivare relazioni al di là della cerchia famigliare…». «Sono un adolescente con qualche problema a scuola: vorrei uscire dalla mia stanza ma quello che c’è fuori mi fa paura, mi rifugio nel mio computer che mi spalanca un mondo, però alla fine resto sempre solo…».
È cominciato con un rosario di vorrei, tratti da storie di fragilità che operatori e volontari Caritas incrociano ogni giorno, uno degli incontri più originali tra quelli che compongono il calendario delle Cattedre della carità. Martedì 8 aprile, nella sede milanese di Caritas Ambrosiana, l’iniziativa varata dall’organismo pastorale in occasione del suo 50° ha proposto una stimolante riflessione sul tema “Carità e Tecnologia”, con la partecipazione di Francesco Caio (top manager che ha ricoperto importanti incarichi pubblici e privati in aziende e settori ad alto tasso di innovazione) e Ivana Pais (docente di Sociologia economica all’Università Cattolica).
Binomio poco esplorato, quello tra carità e tecnologia. Da una parte la virtù teologale più alta, dall’altra la regola dominante della contemporaneità; su un versante la gratuità del dono di sé, sull’altro la gestione utilitaria della natura, del tempo, dello spazio, dell’economia, del lavoro, delle interazioni umane. Sembrerebbe un dialogo tra sordi. Eppure non eludibile, in un’epoca in cui lo sviluppo tecnologico condiziona non soltanto la qualità e persino il senso della vita di ogni individuo, e le relazioni interpersonali, ma anche questioni che strutturano le collettività, sino a mettere in discussione i sistemi democratici e di welfare, e con essi diritti sociali e civili che la Chiesa, e in essa Caritas, reputano fondamentali e inviolabili.
Dobbiamo dunque arrenderci al catastrofismo? Dalla Cattedra è emerso con chiarezza che non dobbiamo diffidare della tecnologia in sé. Ma degli scopi cui è asservita. Soprattutto – hanno a più riprese e con vari esempi evidenziato Caio e Pais – occorre (ri)scoprire e valorizzare le enormi potenzialità che le tecnologie hanno, in termini di annullamento o accorciamento di distanze e diseguaglianze (possono aiutare un anziano a curarsi meglio a casa, una persona disabile a progettare una vita autonoma, un minore a superare i suoi limiti cognitivi o linguistici), a patto di non delegare tutto a esse. La loro applicazione ha sempre bisogno di un contesto relazionale, sociale e formativo; la novità digitale di una presenza analogica che la spieghi, la adatti, la integri; click e app richiedono di essere accompagnati da una parola, un sorriso, un abbraccio portati da un operatore, un volontario, un amico, un famigliare.
È uno sforzo che stanno provando a fare diversi soggetti della solidarietà sociale, tra cui quelli convocati, sempre nello stesso pomeriggio, dalla Commissione Anziani della diocesi (coordinata da Caritas) per un laboratorio di confronto su alcune esperienze in corso. La piattaforma digitale dedicata “Isidora”, creata in pandemia dalla cooperativa La Meridiana a Monza, per mantenere il contatto con gli anziani e offrire loro servizi e stimoli; il progetto “Soli mai”, condotto nel Rhodense dall’azienda speciale consortile dei servizi sociali Sercop; il progetto, finanziato dal Pnrr, avviato nel Lecchese dalla cooperativa L’Arcobaleno e dall’impresa sociale Girasole, per diffondere tecnologie e dispositivi per il controllo a domicilio di persone fragili: esempi (da conoscere, adattare, disseminare) di come è possibile umanizzare la tecnologia, e il suo utilizzo, perché essa aiuti a umanizzare il mondo.