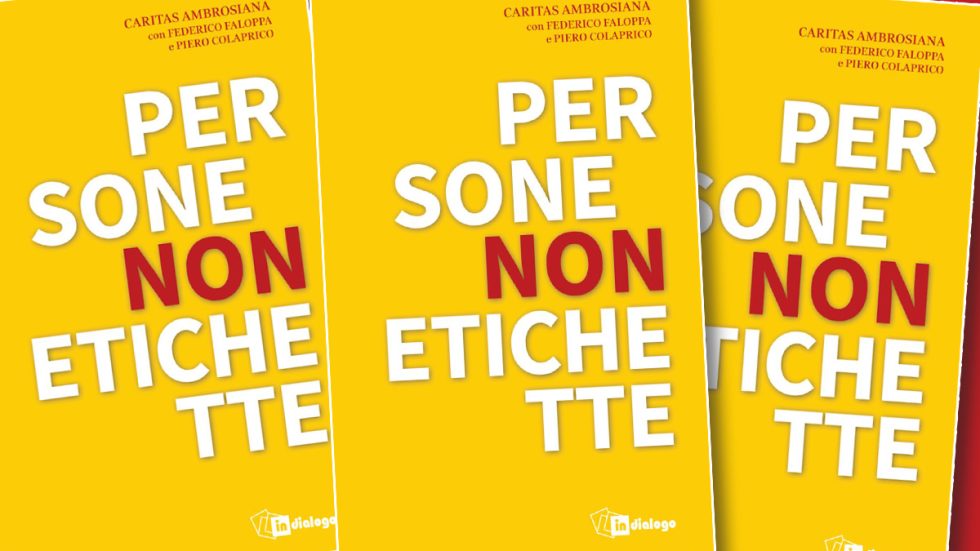Dal 20 novembre sarà disponibile in libreria il volume Persone non etichette (In Dialogo, 96 pagine, 12 euro), a cura di Paolo Brivio con testi di Federico Faloppa e Piero Colaprico. In anteprima pubblichiamo l’introduzione.
di Erica TOSSANI e Paolo SELMI
Direttori Caritas ambrosiana
Etichette. Comode, certo. Aiutano a definire qualità e provenienza di un oggetto. A stabilire un prezzo. A recuperare un fascicolo da un archivio. Ma quando sono applicate all’identità (complessa, contraddittoria, talora persino frantumata, eppure irripetibile) di un essere umano, finiscono per tradire: appiattiscono, categorizzano, stigmatizzano. In definitiva, condannano: a uno status di povertà, di esclusione, di carenza, di colpa. Oltre il quale sembra chiudersi ogni spazio di riscatto, di giustizia, di revisione, di conversione.
Le parole sono materiale delicato. Infiammante e infiammabile. Possono accendere una passione, un percorso, uno o molti cuori. Possono incenerire relazioni, diritti, aspirazioni, persino vite.
Nel caso migliore, infiammano perché riflettono e rispettano la materia volatile e sorprendente, fragile e tenace di cui è fatta ogni esistenza: la materia di cui son fatti i sogni. Nel caso peggiore, sono clava che si abbatte sulla possibilità di riconoscere nell’altro, per quanto diverso, la nostra stessa materia, i nostri stessi sogni, un’origine e un destino comuni. Da fratelli, da sorelle.
C’è un uso opportuno per ogni cosa. La vita, la società, le comunità non sono magazzini da organizzare. E dunque abbiamo un problema, quando le parole si fanno etichette. Quando erigono un pregiudizio a sentenza inappellabile. Quando ostacolano il confronto delle idee, anziché spianare la strada. Quando sacrificano alla pigrizia dei like e alla violenza del consenso di massa il travaglio dell’incontro individuale, del mutuo ascolto, del reciproco riconoscimento.
Abbiamo un problema, quando lasciamo che le parole etichettino le persone. Lo sanno gli uomini e le donne di Caritas, che con autentico disinteresse, ogni giorno, provando a vincere anche i propri limiti (di pazienza, di comprensione, di organizzazione, di risorse), cercano di cogliere le ansie più profonde e le speranze più resistenti di chi è in povertà, di chi sta ai margini, di chi cerca una casa o un lavoro, di chi si sente solo, inadeguato, inaccettato.
Non risponde solo a un interesse accademico accertare se nel linguaggio pubblico, e in quello mediatico, ci sia ancora spazio per un vocabolario di carità. Non possiamo lasciare che le proposizioni d’odio, le proclamazioni di indifferenza, le celebrazioni della superficialità occupino per intero la scena delle espressioni e delle relazioni umane, virtuali o materiali che siano. Ne va della dignità di chi ha minori strumenti per affermare o difendere la propria umanità. Ne va del senso e del valore del nostro stesso ruolo di operatori pastorali, sociali, pedagogici, culturali.
Le tredici piccole storie che sono raccolte in questo libro non ambiscono a codificare, scolpendolo una volta per tutte, un nuovo lessico della solidarietà. Ma intendono mostrare che sotto la crosta della lingua, con le sue necessarie convenzioni e talora semplificazioni, si agita, evolve e matura una materia vitale, talora incandescente, talora rasserenante. Sempre, a essere onesti, sorprendente.
Anche a noi, che professionalmente o volontariamente ci occupiamo del prossimo in difficoltà, e che inevitabilmente ci appropriamo di alcuni concetti e vocaboli, facendone cardine del nostro pensare e del nostro agire, è richiesto di vincere la pigrizia dell’etichetta. Di lasciarci educare dall’unicità delle persone, per versare vino sempre nuovo negli otri del nostro giudizio sulla realtà. La lingua che rispetta la vita, e le sue contraddizioni, e le sue diversità, le sue cadute e le sue risalite, dunque la sua ricchezza: anche questa è una forma di carità. Che siamo chiamati a testimoniare, nella storia di cui siamo cittadini.