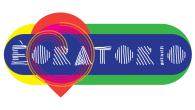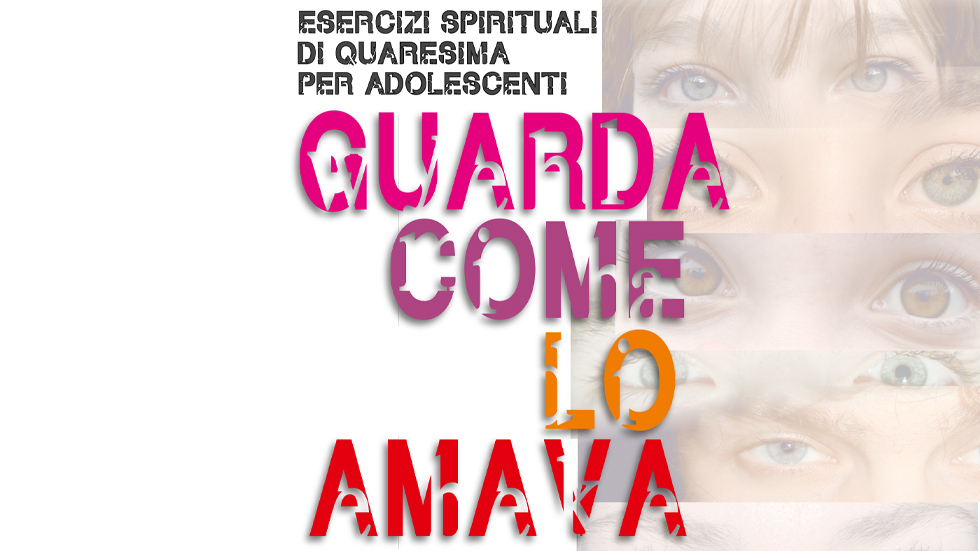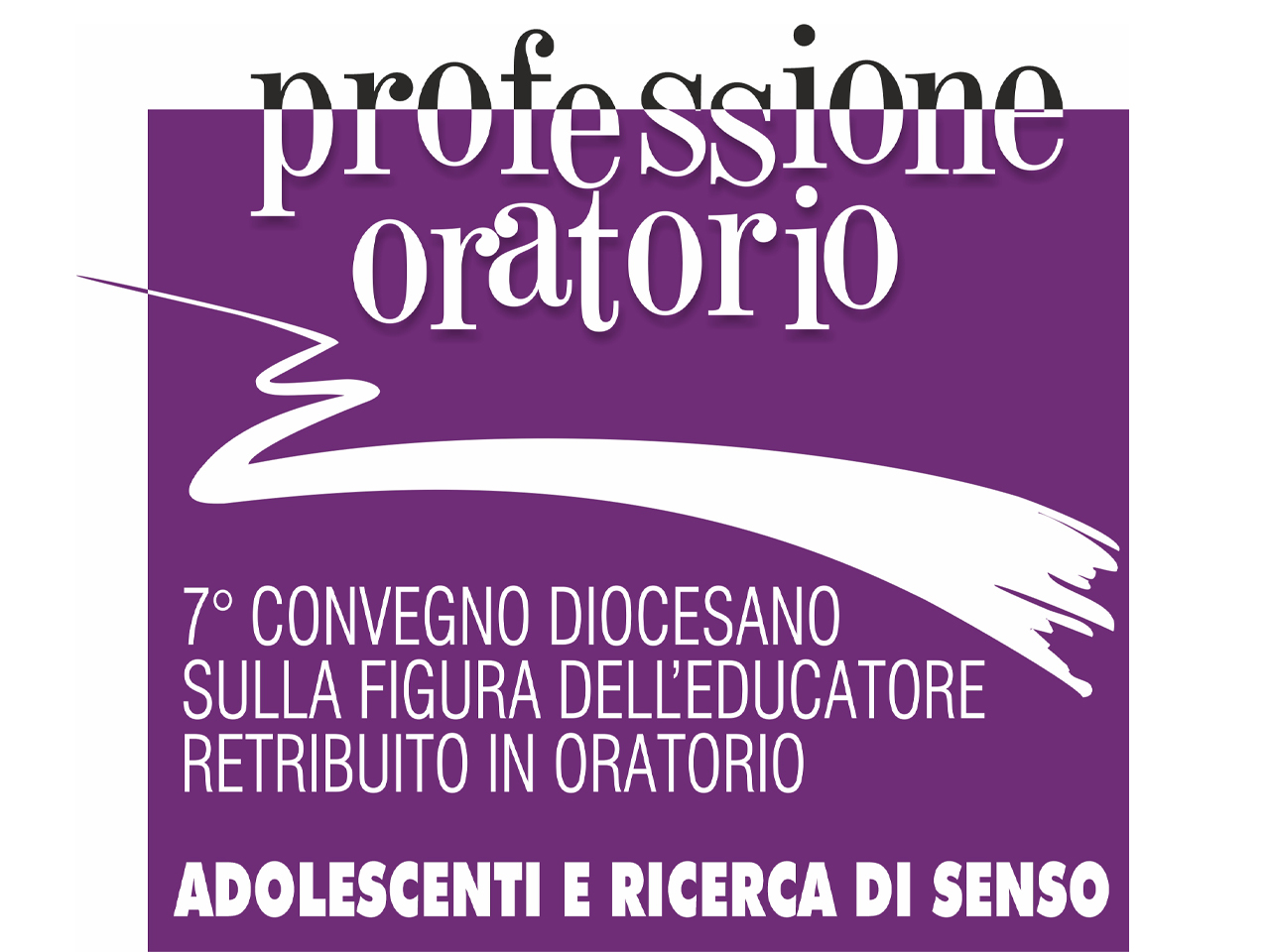Nel quartiere di via Paolo Sarpi a Milano, la comunità cinese è di casa da quasi un secolo. Qui, nella parrocchia della Santissima Trinità, oratorio e scuola di lingua diventano luoghi di incontro e di scambio. Famiglie e ragazzi cinesi scoprono poco a poco la ricchezza della vita oratoriana: dal doposcuola alle gite estive, dal gioco condiviso al pranzo insieme. Un cammino fatto di gradualità, mediazione culturale e relazioni quotidiane, che mostra come l’oratorio possa essere davvero uno spazio di prossimità aperto a tutti. Questa esperienza è stata studiata dai tavoli che sono attivi nel progetto Èoratorio. Fra le linee progettuali che destano l'interesse della nostra riflessione, stiamo investigando come la linea dell’intercultura sia una strada concreta e percorribile, perché gli oratori continuino a svolgere la loro funzione educativa in una società sempre più plurale.
Nel viaggio tra le esperienze di Èoratorio sono protagonisti questa volta i ragazzi della parrocchia Santissima Trinità di via Giusti, nel cuore della “Chinatown” di Milano. Che ha una particolarità rispetto agli altri quartieri: la comunità cinese è da sempre di casa qui, tra via Canonica e via Paolo Sarpi, fin dai primi arrivi negli anni ’30, proseguiti poi nel dopoguerra e ancora in questi anni. Questo è dunque il quartiere di riferimento anche per i cinesi di fede cattolica: la cappellania cinese e la parrocchia non sono proprio la stessa cosa, ma sono di certo strettamente intrecciate. Una presenza radicata, dunque, quella dei cittadini del Dragone. Ma, a differenza di altri gruppi etnici, la comunità cinese tende in genere ad essere autonoma, e, quindi, non sente immediatamente l’esigenza dell’integrazione nel tessuto locale.
In questo contesto, dunque, risalta ancora di più il cammino di accoglienza che si vive in oratorio, e la graduale scoperta dell’ambiente oratoriano da parte delle famiglie cinesi. Che, in molti casi si avvicinano non tanto per trovare uno spazio di relazione per i propri figli, quanto piuttosto per l’esigenza pratica dell’aiuto nei compiti. Oppure per la scuola di lingua e cultura cinese, che il cappellano don Francesco Zhao ha voluto aprire qui nel 2019.
Intendiamoci: per molti aspetti non stiamo raccontando qualcosa che non avvenga anche negli altri oratori. Dove i ragazzi spesso arrivano per il doposcuola, e poi si fermano anche a giocare. Come detto, però, proprio la particolare compattezza della comunità cinese mette in evidenza il percorso di conoscenza reciproca e di amicizia.
Studiare in oratorio la lingua del Dragone
Scopriamo, appunto, che in oratorio non si entra solo per giocare. Anzi. Anche nel tempo libero i genitori guardano al fatto che i figli imparino qualcosa, spiega Francesca, religiosa di origine cinese dell’Ordo virginum, in parrocchia ormai da diversi anni. Un orientamento che va assecondato, sottolinea Francesca, facendo scoprire, via via, che in oratorio anche il gioco si vive con un senso educativo.
Partiamo però dalla scuola di cinese, frequentata da quei ragazzi che, nati in Italia, non conoscono la lingua dei propri genitori. A Milano ci sono certamente tante altre scuole simili, spiega la responsabile Giovanna, anche lei cinese. Ma questa, sottolinea, è una scuola cattolica. Dove la giornata inizia con il Padre nostro e dove, oltre che alla didattica, c’è l’attenzione e la cura per ogni singolo ragazzo, come Giovanna ha spiegato a Emilia Cedeño (mediatrice culturale per la Pastorale Migranti con il progetto “Camminando”) e ad Arianna De Carli (referente per l’Area Interculturale della FOM), che hanno incontrato, studiato e approfondito e questa realtà per la fase immersiva del progetto Èoratorio.
Una scuola che i ragazzi, circa 25 quest’anno, dai dieci anni in su, hanno frequentato anche in estate, dopo la fine dell’anno scolastico. Giovanna ribadisce che per i genitori è estremamente importante che i loro figli sfruttino anche il periodo estivo: «abbiamo fatto sette settimane, per un totale di 35 lezioni: riusciamo quindi a completare un libro. Durante l’anno i ragazzi frequentano il corso al sabato (dunque nel giorno in cui sono liberi dalla scuola), per altre 35 lezioni. In un anno, quindi, facciamo due libri. E poiché il corso è composto di 12 libri, i ragazzi lo completano in sei anni».
Sembrano quindi esserci pochi margini per prendersi del tempo libero, e non si può che provare ammirazione per i ragazzini che studiano dalle 9 alle 16, mentre in cortile gli altri vivono la giornata dell’oratorio estivo. Anche loro, comunque, scalpitano per andare a giocare. Come rivela Francesca, riportando quanto un giorno le ha confidato uno dei piccoli studenti: «è una sofferenza vedere giù gli altri che giocano, mentre noi siamo qui a studiare!».
Ma proprio la condivisione degli stessi spazi e l’esperienza di questi anni ha fatto sì che, soprattutto quest’anno, i momenti passati insieme fossero sempre di più.
La parola chiave è gradualità, osserva Emilia Cedeño, o «bilanciamento», come spiega Giovanna. Che quest’anno, d’accordo coi genitori, ha portato i suoi alunni a tutte e quattro le gite dell’Oratorio estivo, mentre l’anno scorso avevano partecipato solo a due: «ho pensato che, in concreto, è importante non tanto che completino il libro ma che alla fine abbiano imparato la lingua», spiega così la scelta. C’è poi, ogni giorno, il pranzo insieme a tutti gli altri. E, verso la fine della lezione, uno dei ragazzi più grandi si stacca dalla classe per fare, anche solo nel pomeriggio, l’animatore.
«Così, piano piano, anche per i ragazzi le cose cambiano: negli ultimi giorni dell’oratorio, quando faceva veramente caldo e hanno fatto i giochi con l’acqua, i ragazzi erano veramente uniti, tutti hanno giocato insieme: è stato un grande risultato», commenta soddisfatta Giovanna.
Buone pratiche di ospitalità
Naturalmente la diversità linguistica può essere un ostacolo quando c’è da giocare insieme. Così in oratorio è per lo più Francesca che fa da interprete. Ma anche i bambini che conoscono sia il cinese che l’Italiano sono sempre disponibili a tradurre ai loro coetanei, assicura don Attilio Anzivino, che è parroco qui da due anni. A favorire l’accoglienza c’è poi uno stile di ospitalità (che naturalmente non vale solo qui).
«Non bisogna pensare che un altro non capisca solo perché non conosce la lingua; e a volte per far sentire accolto un bambino basta anche solo un bel “ciao!”», ricorda Francesca.
I bambini cinesi peraltro «salutano sempre, a differenza di quanto avviene con gli italiani», chiosa don Attilio. E, sollecita sempre Francesca, «bisogna interessarsi alla cultura dell’altro, perché ciascuno ha la sua ricchezza». Ora, ad esempio, tutti giocano a “Go”, il nome con cui in Italia conosciamo il “wuziqi”, il gioco cinese con le pedine bianche e nere, dopo che Amelia, l’educatrice responsabile dei ragazzi, ha avuto l’idea di portarlo in oratorio.
Queste settimane estive hanno mostrato dunque che si possono fare esperienze insieme, si può diventare amici anche se, per alcuni, la giornata è scandita in modo differente. Mentre, allo stesso tempo, le famiglie cinesi iniziano via via a comprendere il valore di ciò che si fa in oratorio.
Alle spalle, naturalmente, c’è una consuetudine e un’apertura reciproca che si vive durante tutto l’anno. Giovanna spiega ad esempio che in inverno la scuola di cinese sempre nei locali dell’oratorio, dove il sabato mattina non c’è nessuno: ma poter usare il bar è molto utile, perché così i bambini, con le caramelle, possono imparare a gestire la paghetta.
Tutta la comunità festeggia poi il Capodanno cinese: l’anno scorso, ricorda sempre Giovanna, abbiamo fatto anche il drago gigante. Da alcuni anni, poi, ogni 24 maggio, in cui si celebra la Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, i ragazzi vivono un giorno di gita-pellegrinaggio, sempre accompagnati da Giovanna. Una volta a Napoli, mentre quest’anno a Bergamo, con tanto di sacco a pelo, insieme anche a don Alberto Vitali, il responsabile diocesano della Pastorale dei Migranti. «Solo la metà dei ragazzi, o forse meno, sono di famiglia cattolica», precisa Giovanna. «Ma – sottolinea – io presento le cose con cautela, e loro vengono perché si fidano».
Volontari fondamentali per fare intercultura
Francesca rimarca come sia importante la presenza di chi, conoscendo la lingua e la cultura cinese, può svolgere una funzione di mediazione con le famiglie, come lei stessa fa spesso offrendosi per accompagnare i genitori nei colloqui coi professori. E, richiamando il passo del Vangelo sulla scaltrezza dei «figli di questo mondo», provoca la comunità lanciando l’invito a coinvolgere i tanti universitari cinesi presenti che studiano in città, e che ora guadagnano qualcosa insegnando la lingua o la calligrafia cinese nelle varie scuole private. Don Attilio in effetti constata che più di un adolescente, sia italiani che cinesi, si propone come animatore. «Certo, se avessimo anche altre figure fisse come mediatori culturali, oltre ad Arianna e Francesca, saremmo ancora più facilitati. Ma ai ragazzi – ribadisce – propongo comunque la logica del servizio.
Non manca d’altra parte, sia al doposcuola che in estate, un numeroso gruppo di volontari adulti che si prendono cura dei ragazzi. In qualche caso, spiega don Attilio, «andiamo dalle stesse famiglie, magari nei loro negozi, per invitare i loro figli all’oratorio». E, in fondo, i bambini sono tutti uguali, chiosa Paolo, uno dei volontari del doposcuola che si è guadagnato l’appellativo di “Yéyé”, “nonno” in cinese.
L’oratorio è spazio di prossimità interculturale
«L’aspetto dell’apertura al prossimo che si vive in oratorio non è comunque scontato», sottolinea Arianna, mentre Emilia osserva che, pur nella distanza linguistica, proprio la cornice comune della fede rappresenta un punto d’incontro. E se non sarebbe naturalmente possibile avere un mediatore culturale in ogni parrocchia, dall’esperienza della “Chinatown milanese” Arianna ed Emilia traggono però alcune indicazioni che possono essere utili anche in altre realtà: l’oratorio, suggeriscono, «può essere per tutti uno spazio di prossimità»: così «un incontro coi genitori di origine non italiana potrebbe essere utile per facilitare una prima conoscenza. E, allo stesso tempo – sollecitano – i volontari dei doposcuola potrebbero fare qualche passo in più approfondendo la cultura di provenienza dei ragazzi. Questo non porterà magari ad avere competenze specifiche, ma è già un primo passo».
Che cos’è Èoratorio?
Èoratorio è il progetto che la FOM sta realizzando per ripensare l’oratorio in relazione alle nuove sfide educative, affinché l’oratorio possa rispondere ancora meglio alle esigenze e ai bisogni delle nuove generazioni, continuando a offrire la prospettiva della fede e gli strumenti necessari per crescere in modo integrale, con proposte di prossimità e ospitalità che siano al passo con la vita dei ragazzi e delle ragazze.
Èoratorio è un percorso lungo che durerà almeno fino al 2027, con l’obiettivo di “consegnare” progettualità e opportunità nuove per l’oratorio. Prenderanno forma grazie a una sperimentazione “sul campo” che avrà un fondamento solido e un riscontro scientifico, attraverso lo studio delle scienze umane e della teologia pastorale.
Il progetto Èoratorio ha mosso i suoi primi passi già nel corso del 2024, per strutturarsi e darsi una metodologia fondata e affidabile che permetterà di continuare la progettazione per altri tre anni di lavoro, con un investimento di persone e risorse che intercettano diversi mondi ecclesiali e servizi diocesani.
Intercultura, orientamento, aggregazione, spiritualità sono solo alcuni degli “orizzonti” con i quali si confronterà il progetto Èoratorio, per riaffermare l’identità, la funzione e l’efficacia educativa dell’oratorio in questo tempo di cambiamenti in atto, nel quale è la vita dei ragazzi e delle ragazze, di preadolescenti e adolescenti, a cambiare sempre più velocemente.
Il Gazzettino della FOM – numero speciale dedicato a Èoratorio
Linee progettuali, finalità, composizione (pdf)
Èoratorio, significato, slogan e logo (pdf)
Video di presentazione (Youtube)
Leggi l’articolo sulla presentazione del progetto (Chiesadimilano.it)
Playlist ufficiale del progetto Èoratorio
Video degli interventi all’Incontro di presentazione del 12 novembre 2024
Il progetto Èoratorio non è “solo un’idea”, ma una vera e propria sfida per ripensare gli oratori come luoghi centrali di educazione e incontro nella società di oggi. Il 12 novembre scorso abbiamo organizzato un incontro a Milano con i principali protagonisti del progetto: i membri del Tavolo tecnico di progetto con operatori della FOM e altri provenienti da diversi soggetti ecclesiali e i membri del Comitato scientifico di ricerca che coinvolge l’Università Cattolica, l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il Seminario di Milano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
Sono intervenuti don Giuseppe Como, Presidente della FOM e Vicario episcopale per la celebrazione e l’educazione della fede, don Stefano Guidi, direttore della FOM, don Claudio Burgio, che collabora con il progetto, Antonino Romeo, referente dell’area progettazione della FOM. E poi Cristina Pasqualini e Giulia Schiavone, che hanno spiegato l’approccio interdisciplinare e le prime esperienze di ricerca sul campo, e suor Rosina Barbari, che ha offerto una riflessione profonda sul significato degli oratori come spazi vivi e in dialogo con il territorio.