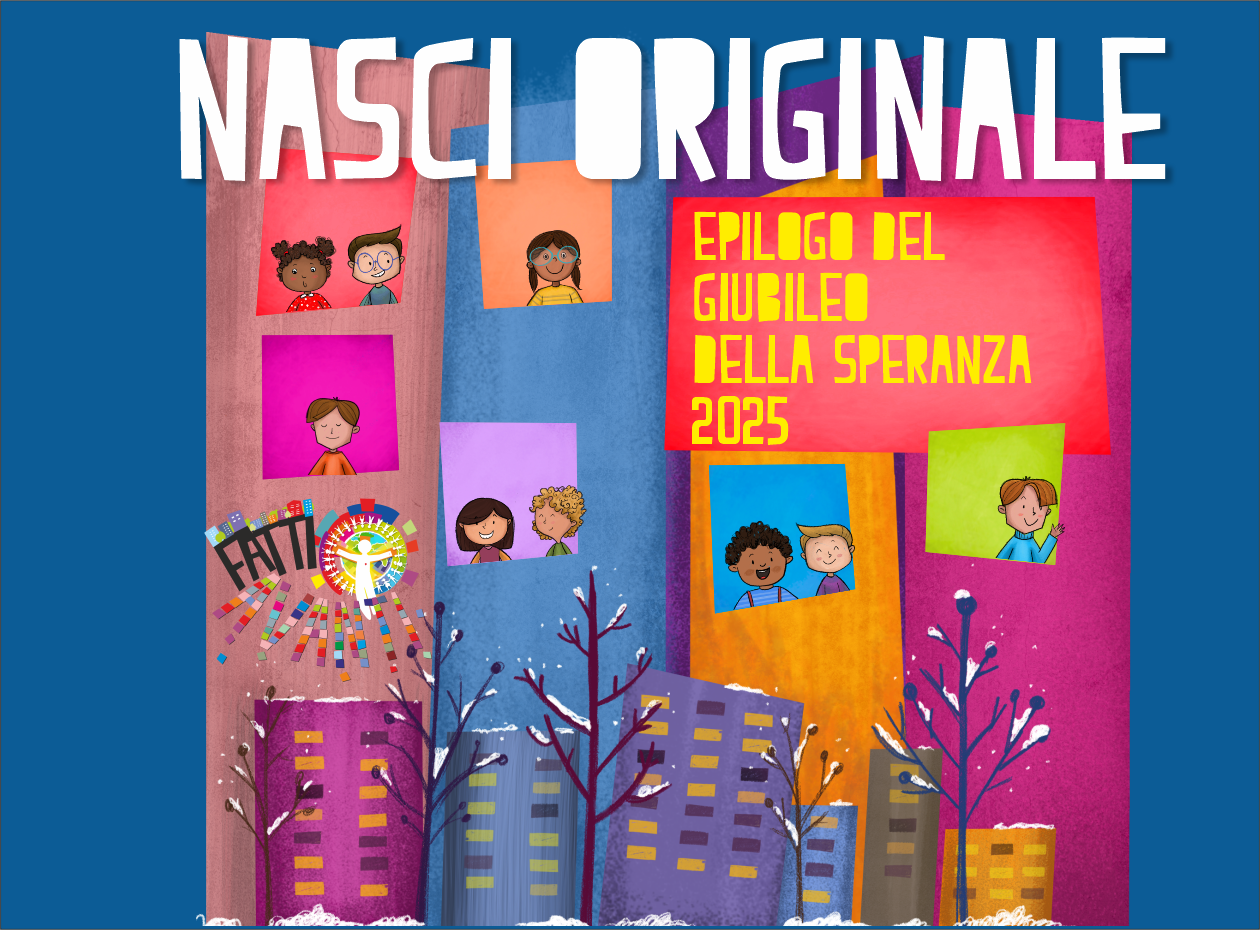Proponiamo qui l'introduzione al fascicolo "Fatti avanti" per l’anno oratoriano 2025-2026 del nostro direttore, don Stefano Guidi. È un invito a leggere con lucidità il tempo presente, riconoscendo le sfide che gli oratori ambrosiani sono chiamati ad affrontare: il cambiamento del senso del tempo (soprattutto della domenica), la questione delle comunità educanti e la trasmissione della fede attraverso l'oratorio. Se non nascondiamo alcuni aspetti critici, comunque riaffermiamo che l’oratorio non si tira indietro, anzi si fa avanti. Nel testo si intrecciano tre prospettive fondamentali per il cammino del prossimo anno oratoriano: la proposta di animazione educativa “Fatti avanti!”, il percorso di rinnovamento del progetto Èoratorio e la riflessione sull’alleanza tra Oratorio e Sport che coinvolgerà in particolare chi si occupa della regia educativa negli oratori. Rimandiamo per una riflessione completa al fascicolo "Fatti avanti" allegato a Il Gazzettino della FOM n. 5 in arrivo in ciascun oratorio ambrosiano nel mese di agosto.
Don Stefano
Guidi
Direttore della Fondazione Oratori Milanesi
Fatti avanti
Fatti avanti è il titolo della proposta dell’anno oratoriano 2025- 2026. È il modo con cui l’oratorio porta il messaggio pastorale dell’Arcivescovo Mario ai ragazzi e agli adolescenti della nostra Chiesa ambrosiana, invitandoli a prendere parte all’esperienza di sinodalità che stiamo vivendo.
L’oratorio intende introdurre nella Chiesa sinodale, invitando ciascuno a lasciarsi coinvolgere dalla Parola del Signore Gesù che chiama a seguirlo.
L’oratorio non intende fare altro che amplificare e diffondere la chiamata di Gesù ad accogliere lo Spirito che ci rende figli e figlie e ci rende capaci di amare, così come siamo amati dal Padre. L’oratorio non vuole fare altro che proporre a tutti la Parola di Gesù che chiama a seguirlo nella comunità dei discepoli, aprendo il nostro cuore, la nostra mente e le nostre mani all’azione dello Spirito che tutto cambia e che rende ciascuno di noi pieno di vita. L’oratorio vuole anche essere uno spazio e un tempo in cui provare a dare forma – personale e comunitaria – alla nostra risposta alla proposta di Gesù. In oratorio prendono forma concreta la sua proposta e la nostra risposta. Lì si costituisce una prima esperienza di amicizia nella fede, che deve superare i confini fisici dei nostri cortili e abbracciare tutta la vita, ravvivando la nostra memoria e scaldando i nostri cuori.
«Cari amici, voi siete fortunati perché nelle vostre parrocchie ci sono gli oratori, un grande dono della Diocesi di Milano. L’oratorio, come dice la parola, è un luogo dove si prega, ma anche dove si sta insieme nella gioia della fede, si fa catechesi, si gioca, si organizzano attività di servizio e di altro genere, si impara a vivere, direi. Siate frequentatori assidui del vostro oratorio, per maturare sempre più nella conoscenza e nella sequela del Signore!»
(Benedetto XVI, Stadio San Siro, 2 giugno 2012).
Per molti ancora oggi, in oratorio si accende la vita del nucleo più intimo della nostra fede: per molti diventerà una scintilla che illumina e orienta l’esistenza, per molti altri suonerà come un richiamo alla bontà originale di cui siamo plasmati, per molti altri ancora sarà la speranza di recuperare qualcosa che abbiamo perso, per altri e altri ancora sarà dolce memoria da cui attingere energia nei passaggi delicati della vita.
A farsi avanti è innanzitutto il Signore Gesù che ci guarda con amore (Mc 10,21), ci chiama per nome (Mt 9,9) e ci chiede: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38 e 18,4). Questa domanda di Gesù ci aiuta a prendere coscienza di noi stessi e della nostra situazione di vita. Non è la domanda di un giudice o di un arbitro, ma di un amico che ci tende la mano e chiede di poter camminare accanto a noi.
Con lo stesso animo, l’oratorio cerca i ragazzi e desidera sostenere la loro ricerca. Ciò significa che la vocazione si scopre camminando e crescendo insieme nella relazione. Soltanto disponendoci a una relazione di amicizia fraterna è possibile aiutare i nostri ragazzi e adolescenti a scoprire la loro vocazione e decidere di farsi avanti.
A farsi avanti quindi sono le comunità educanti, chiamate ogni anno a rinnovare la propria fede nel Signore che educa il suo popolo. Le comunità educanti possono offrire relazione nella misura in cui esse stesse vivono di relazioni vere. Non può bastare la condivisione dei programmi e nemmeno la collaborazione nella realizzazione delle attività. I nostri oratori soffrono spesso di attivismo sterile: le tante cose che si fanno non sappiamo più dire perché si fanno e per chi si fanno. Talvolta la rivalità e la contrapposizione prevalgono sulla collaborazione e la riconciliazione. Così la comunità cristiana deperisce e si svuota. Le comunità educanti possono essere invece una esperienza di servizio che ci aiuta a essere adulti educatori e quindi donne e uomini migliori.
Quando i ragazzi e gli adolescenti crescono in una comunità cristiana che, naturalmente e spontaneamente, vive relazioni cordiali e che è attenta ai bisogni umani, che, senza cadere nell’ossessione della perfezione, cerca di lavorare sui propri peccati ed errori, si appassionano a uno stile che pian piano plasma la loro umanità. Perché ci sia un oratorio è necessario che ci siano comunità educanti. Non solo un prete, non solo degli incaricati, non solo degli allenatori che si curano dello sport, dei baristi che si curano del bar, dei catechisti che si curano del catechismo, dei volontari che si curano della cucina.
«Una comunità educante: tutti quelli che nei diversi ambiti si curano dei ragazzi e delle ragazze dell’oratorio e condividono la stessa passione, le stesse convinzioni, le stesse relazioni e gli stessi riferimenti. È gente che ha molte doti, ma non pretende di essere perfetta. È gente che non fa le cose per forza, ma per passione. È gente che ha una misteriosa riserva di gioia e di buona volontà. Non tutti sono teologi o ingegneri o intellettuali o manager. Una cosa hanno in comune. Vanno a messa la domenica e amano il loro oratorio».
(Mario Delpini, omelia nel centenario della FOM, Duomo di Milano 26 gennaio 2024)
Fatti avanti non è un ordine, un’ingiunzione o un rimprovero rivolto ai più giovani. È l’atteggiamento quotidiano con cui un oratorio intende comunicare ai suoi ragazzi l’amore ricevuto, per iniziativa del Padre.
Èoratorio
La seconda prospettiva che intendo presentare per questo anno oratoriano è quella aperta dal progetto Èoratorio.
Da tanti anni si discute sugli oratori. Li teniamo? Li chiudiamo? Li cambiamo? I cambiamenti macroscopici che stanno avvenendo e la serietà dei problemi educativi e pastorali che chiedono di essere affrontati, lasciano la comunità cristiana smarrita e frastornata. E tuttavia l’oratorio – superata la stagione terribile del Covid – continua a dare segnali straordinari di vitalità e vivacità, grazie soprattutto alla passione generosa e intelligente dei nostri preti e delle nostre comunità cristiane.
Ripensare insieme l’oratorio ambrosiano a partire dalle molteplici trasformazioni in atto è la meta dell’esperienza di Èoratorio.
Mi sembra di poter dire che la stagione gloriosa dell’oratorio, quella che molti tra noi ricordano con tanta nostalgia, faceva affidamento su almeno tre elementi di indiscussa solidità, che oggi sono diventati invece elementi di grande criticità.
Il primo elemento di criticità – che un tempo era solido e affidabile – è la domenica. L’oratorio, fin dal suo esordio, nasce per aiutare i più piccoli a distinguere il Giorno del Signore dagli altri giorni della settimana. Il Giorno del Signore si vive in un certo modo: è il tempo dedicato al riposo, alle relazioni famigliari e di amicizia, è il tempo dedicato alla preghiera e alla celebrazione comunitaria, è il tempo del gioco, del servizio e della formazione religiosa. Attorno al Giorno del Signore e della Comunità, l’oratorio ha elaborato il suo originale metodo educativo che definiamo animazione. È poi avvenuto come uno sviluppo che ha integrato il tempo libero quotidiano, il tempo serale (come ritrovo per i più giovani), il tempo estivo.
Dall’animazione del Giorno del Signore, l’oratorio ha saputo sviluppare una proposta di animazione che incontrasse le esigenze di relazione e i bisogni di crescita della vita dei ragazzi, degli adolescenti fi no ai giovani. Dall’animazione del tempo si è strutturato lo spazio, e non viceversa. Infatti, lo spazio messo a disposizione senza una proposta di senso è del tutto inutile e insufficiente.
Qui notiamo il primo elemento di criticità. A fronte di una proposta ampia e popolare sono proprio le famiglie, i ragazzi e gli adolescenti ad avere sempre meno tempo da dedicare alla proposta dell’oratorio.
Da una parte la secolarizzazione culturale influenza anche il senso attribuito al tempo festivo: non è più il tempo del Signore e il tempo della comunità, ma è il tempo per sé, a propria disposizione, per i propri impegni e attività personali o famigliari. Dall’altra parte, gli impegni scolastici, la gestione dei tempi familiari e le svariate offerte di intrattenimento, di consumo di socializzazione occupano gran parte del tempo una volta lasciato libero e che la proposta oratoriana riusciva a intercettare brillantemente.
Prova ne è il fatto che i nostri oratori si sono riempiti di un po’ di tutto: dal bar alla sala prove, dal teatro alla palestra.
Una proposta che ad un certo punto si è ripensata completamente per rispondere al bisogno della gente di incontrarsi, di stare insieme, di realizzare qualcosa e di fare comunità.
Unica eccezione è il tempo estivo, su cui non parleremo ora.
Rimane però aperta una grande questione: la frequentazione solo estiva dell’oratorio è sufficiente alla maturazione di una relazione significativa con l’esperienza credente e con la comunità cristiana? Qui rileviamo una grande sfida per l’oratorio: la capacità – e prima ancora l’intenzionalità – di disporsi a offrire una relazione significativa, considerando che i tempi che i ragazzi e gli adolescenti a cui si rivolge possono mettere a disposizione, sono drasticamente ridotti.
E considerando ancora che il significato che i ragazzi e gli adolescenti attribuiscono al tempo della formazione religiosa è ridotto ai minimi termini. Se non c’è altro, l’ingiunzione familiare può molto poco. Ecco la domanda: l’estate può bastare? Gli eventi possono bastare se manca la quotidianità?
Il secondo elemento di criticità – un tempo invece di solidità – sono le comunità educanti. Per dirla con parole povere, l’insieme delle donne e degli uomini di buona volontà che rendono possibile la proposta dell’oratorio per ciascuna delle fasce d’età grazie alla loro generosità, al loro impegno, alle loro capacità, al tempo speso per i ragazzi.
Mi domando quali fattori insistono sulle dinamiche delle comunità educanti.
In primo luogo, dobbiamo considerare che viviamo in una società dove tutti lavorano e lavorano per molti anni e che la naturale complicità educativa tra adulti è sempre più sostituita dalla conflittualità educativa tra adulti. Le persone hanno meno tempo da dedicare agli altri e hanno meno tempo da dedicare ai figli e ai nipoti degli altri, anche per evitare di avere a che fare con gli altri.
In secondo luogo, dobbiamo considerare i cambiamenti introdotti nelle comunità parrocchiali, con la necessità di intraprendere forme di collaborazione pastorale più ampie e stabili. Mi riferisco all’introduzione delle comunità pastorali, come forma di collaborazione stabile e organizzata tra le parrocchie.
Questa nuova situazione richiede progressivamente alle parrocchie di lavorare insieme e di rivedere le proprie tradizioni, i propri progetti educativi e la destinazione d’uso delle proprie strutture in relazione alle tradizioni e strutture di altre parrocchie. Con quale esito? È in corso un grande lavoro di ripensamento delle proposte e delle strutture oratoriane, con una bella creatività. Accanto a questo, alcuni oratori stanno per essere alienati. Altri sono già chiusi da un pezzo. Altri sono stati ripensati secondo la scelta di specializzazione per età o per attività. Gli interventi che modificano i progetti e le strutture hanno inevitabili ricadute sulle comunità educanti, sulla loro organizzazione e sui loro obiettivi.
Infine, la necessità di introdurre educatori professionali, oltre a determinare l’aumento dei costi della realizzazione della proposta oratoriana, laddove la parrocchia comincia a capire che lo stile della gratuità non corrisponde più semplicemente al “costo zero”, chiede di lavorare con particolare attenzione sulla relazione tra educatori professionali e laici impegnati in oratorio e tra educatori professionali e figure religiose.
Anche qui vediamo una bella e grande sfida per l’oratorio che deve scommettere tutto quello che ha sulla potenzialità umanizzante della propria esperienza educativa e anche sulla capacità di imparare le “regole del gioco” sociale, per stare in questo mondo come un soggetto capace di relazione con gli altri soggetti del proprio territorio.
Il terzo elemento di criticità – un tempo invece di solidità – è la Messa della domenica, e più in generale la possibilità di pensare ancora l’oratorio come uno strumento efficace di evangelizzazione.
Il passaggio dal cortile all’altare non è mai stato automatico per nessuno e da nessuna parte. Senza mitizzare il passato, occorre quindi prendere atto della situazione attuale, caratterizzata dalla secolarizzazione spinta e dalla limitazione forzata dell’esperienza religiosa nella sfera privata individuale e dalla rapidità dell’innovazione tecnologica, che sta modificando l’antropologia e di conseguenza la spiritualità. Quale Vangelo proporre in questo contesto e come proporlo? La riflessione avviata nello scorso anno pastorale sul rapporto tra Oratorio e fede ci offrirà spunti interessanti per continuare nella nostra ricerca.
Nell’ambito di quella riflessione abbiamo cercato di metterci in ascolto della esperienza di catecumeni adolescenti. L’interesse non è ovviamente dettato da ragioni quantitative. Ci interessa invece capire come in un adolescente di oggi arriva o si accende la fede, o come un adolescente di oggi può scoprirla e condividerla.
Anche qui l’oratorio ha una bella sfida da raccogliere: va superata l’idea che la fede si trasmette per trasferimento di informazioni religiose e che si diffonde per comunicazione emotiva, e recuperare il senso di una fede come dono, che accade nella vita personale per iniziativa dello Spirito che precede – e nello stesso tempo provoca – l’azione ecclesiale e che inizia una storia nuova.
L’oratorio, evitando un approccio produttivo, quantitativo e selettivo, continua a cercare il modo migliore per servire la fede di tutti.
In definitiva, questi tre elementi di criticità ci invitano a lavorare a partire da una grande domanda: dove si generano oggi relazioni nuove per un oratorio nuovo? I nuovi modelli di oratorio non saranno idee geniali di qualcuno. Proveremo invece ad intuire insieme a partire da quali attese e bisogni umani, educativi e sociali, sia possibile accendere relazioni nuove e vitali per l’oratorio.
Oratorio e Sport
La terza prospettiva che intendo presentare ci impegnerà a confrontarci sul rapporto tra Oratorio e Sport.
L’occasione per lavorarci ci viene offerta dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
Nel fascicolo troveremo tutti gli approfondimenti necessari e nel corso dell’anno pastorale forniremo ulteriori aggiornamenti e materiali.
La tappa iniziale del percorso che coinvolgerà principalmente la regia educativa degli oratori sarà la Due Giorni “PensiAmo l’oratorio”, alla quale sono invitati tutti i responsabili degli oratori, a Seveso il 14-15 ottobre 2025.
Qui vorrei brevemente richiamare le ragioni di questa scelta e gli obiettivi attesi.
È davvero interessante notare quando e perché l’attività sportiva entra in oratorio. Siamo agli inizi del Novecento, in un contesto sociale in cui lo sport è un’esperienza d’élite: non lo praticano i più capaci, ma i più abbienti. L’oratorio ha questa intuizione: rendere popolare ciò che è per pochi. Mi sembra di poter cogliere qui un grande valore, anche per noi oggi: è necessario reagire, con intelligenza e coraggio, di fronte a vecchie e nuove forme di discriminazione sociale, come quelle di genere, di provenienza, di età, di capacità fisica.
E ancora, reagire a uno sport determinato dal potere economico, dalla prestazione fisica e dai risultati.
Cioè l’insieme delle condizioni esistenziali che potenzialmente minano la pari dignità tra le persone, per cui alcuni contano meno di altri, in piena contraddizione con il Vangelo.
È un principio di valore che precede gli strumenti con cui lo sport viene promosso e difeso. C’è poi una questione che rimanda alla forma organizzativa delle società sportive in relazione alla parrocchia e all’oratorio e a come alimentare questa relazione.
C’è infine la dimensione educativa e progettuale che ci invita a trovare la modalità più adeguata perché l’attività sportiva organizzata possa essere un elemento che contribuisce alla vita della comunità oratoriana e, più oltre, della società.
Cercheremo di fare questo lavoro non attraverso dichiarazioni di principio, che lasciano il tempo che trovano, ma fornendo agli oratori strumenti di dialogo e di progetto, per costruire qualcosa insieme e per chiarire qualche aspetto critico. Ringrazio da subito i Comitati provinciali del CSI di Milano, Varese e Lecco, la cui presenza e collaborazione è indispensabile per la vita dei nostri oratori e per svolgere armonicamente questo lavoro progettuale.